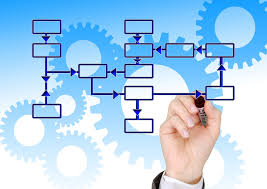In tema di società a partecipazione pubblica, la giurisdizione sull’azione di responsabilità proposta nei confronti degli organi sociali per i danni arrecati al patrimonio della società spetta alla Corte dei conti soltanto se sussistono i seguenti requisiti, che consentono di qualificare l’ente come società in house providing:
a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati;
b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.
Soltanto in presenza di tali condizioni, che devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all’epoca cui risale la condotta illecita, la società può essere assimilata ad un’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico, con il conseguente superamento della distinzione tra le rispettive personalità giuridiche e dell’autonomia patrimoniale della società, che ordinariamente escludono la configurabilità di un rapporto di servizio tra il socio pubblico ed i soggetti che hanno agito nella veste di organi sociali, nonché l’imputabilità al primo del pregiudizio arrecato al patrimonio della società. Tali principi sono stati sostanzialmente recepiti dall’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha stabilito che gli stessi “sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”, facendo tuttavia salva “la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”.
La definizione di società in house ex art. 2, lett. o), del d.lgs. n. 175 del 2016, subordina l’operatività della predetta qualificazione alla configurabilità di un controllo analogo esercitato, in via alternativa, individualmente da un’amministrazione o congiuntamente da più amministrazioni, senza richiedere la coincidenza di queste ultime con tutte quelle titolari di una partecipazione al capitale sociale.
La configurabilità di una società a partecipazione pubblica come società in house, giustificandone l’assimilazione ad un’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico titolare della partecipazione sociale, cui è immanente il rapporto di servizio tra quest’ultimo e gli amministratori o i dipendenti della società, comporta il superamento della distinzione tra le rispettive sfere giuridiche e patrimoniali, consentendo di qualificare come danno erariale, cioè come pregiudizio arrecato direttamente al socio pubblico, quello subìto dal patrimonio della società per effetto della mala gestio degli amministratori o dei dipendenti: a tali società non è quindi applicabile il principio, operante in tema di società di capitali e normalmente riferibile anche a quelle a partecipazione pubblica, secondo cui la distinzione tra la personalità giuridica della società e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dello ente.
Tale conclusione non si pone in contrasto con il disposto dell’art. 12, c.2, del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale si limita ad includere nella nozione di danno erariale anche il pregiudizio eventualmente arrecato al valore della partecipazione sociale dell’ente pubblico dalla condotta dei suoi rappresentanti o comunque delle persone fisiche titolari del potere di decidere per esso, il quale, incidendo direttamente sul patrimonio del socio pubblico, costituisce un danno distinto ed ulteriore rispetto a quello subìto dal patrimonio della società per effetto della mala gestio degli amministratori o dei dipendenti della stessa. Pertanto, nessun rilievo può dunque assumere la circostanza che nel caso di specie, la ricorrente non abbia rivestito la qualifica di rappresentante della Regione, risultando sufficiente, ai fini della configurabilità del danno erariale, che nella gestione dei fondi assegnati alla società in house ella abbia agito in qualità di dipendente della società, il cui pregiudizio è stato allegato a sostegno della pretesa risarcitoria. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, ordinanza del 1/10/2021 n. 26738.